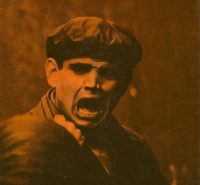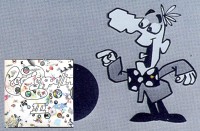Oggi è il ventiquattresimo anniversario della morte di Georges Perec. Posto qui, dopo averlo rivisto, un articolo che scrissi qualche anno fa per “Storie“
 Il 3 marzo del 1982 muore, a 46 anni, Georges Perec. Questa estrema ‘sparizione’ conclude emblematicamente la storia personale di uno scrittore che ha fatto dell’assenza, degli eventi di lenta o repentina scomparsa e dei tentativi di recupero uno degli elementi centrali della sua scrittura.
Il 3 marzo del 1982 muore, a 46 anni, Georges Perec. Questa estrema ‘sparizione’ conclude emblematicamente la storia personale di uno scrittore che ha fatto dell’assenza, degli eventi di lenta o repentina scomparsa e dei tentativi di recupero uno degli elementi centrali della sua scrittura.
Tredici anni prima era uscito presso Gallimard il suo romanzo ‘La Disparition’. Un opera che non è eccessivo definire sconvolgente: si tratta infatti infatti del primo romanzo lipogrammatico mai pubblicato: oltre 300 pagine dalle quali è completamente assente (da cui la sparizione del titolo) la vocale ‘E’, la più frequente nella lingua francese.
Questa operazione apparentemente folle non è altro che un’applicazione radicale della contrainte (letteralmente: costrizione), il caposaldo teorico dell’ OuLiPo (Ouvroir de Litterature Potentielle). Questo gruppo, creato da Raymond Queneau e Francois Le Lionnais, elaborò la pratica di una Letteratura Potenziale che, attraverso la imposizione di rigidi vincoli (intesi fondamentalmente come regole di un gioco che impegna lo scrittore in una sfida alla propria creatività), si propone come un motore di nuove possibilità per la scrittura. Perec – che era anche un enigmista e cultore di giochi linguistico/letterari- diventò ben presto uno dei membri più assidui e rigorosi di questo laboratorio. Italo Calvino, che pure ne fu un celebre frequentatore, scrisse: “per sfuggire all’arbitrarietà dell’esistenza Perec (…) ha bisogno di imporsi delle regole rigorose (anche se queste regole sono a loro volta arbitrarie). Ma il miracolo è che questa poetica che si direbbe artificiosa e meccanica dà come risultato una libertà e una ricchezza d’inventiva inesauribili”.
Ma ‘La Disparition’ (che venne seguita, nel 1972, da ‘Les revenants’, libro complementare in cui è presente soltanto la vocale ‘E’) è solo la più particolare delle opere di un grande scrittore che ci ha lasciato alcuni libri splendidi ed importanti, a volte molto diversi tra loro, felice incontro di poesia, genuino gusto del raccontare e stupefacenti acrobazie formali: a partire da ‘Le cose’ (il primo romanzo, del 1965) fino all’ultimo ‘Storia di un quadro’, passando attraverso quello che viene ritenuto il suo capolavoro: ‘La vita istruzioni per l’uso’, del 1978.  E, sebbene ogni opera abbia una propria identità e una diversa organizzazione formale, alcuni elementi-base ritornano con regolarità quasi ossessiva e, una volta entrati in sintonia più profonda con essi, si rivelano essere, in connessione tra loro, elementi costitutivi di un disegno significativo, concluso, strutturato come un puzzle (non a caso il modello formale di riferimento de ‘La vita istruzioni per l’uso’, grandiosa descrizione delle 100 stanze di un palazzo parigino, con i loro occupanti e tante storie che si incastrano tra loro). Un puzzle che si rivela alla fine essere la vita stessa dell’autore.
E, sebbene ogni opera abbia una propria identità e una diversa organizzazione formale, alcuni elementi-base ritornano con regolarità quasi ossessiva e, una volta entrati in sintonia più profonda con essi, si rivelano essere, in connessione tra loro, elementi costitutivi di un disegno significativo, concluso, strutturato come un puzzle (non a caso il modello formale di riferimento de ‘La vita istruzioni per l’uso’, grandiosa descrizione delle 100 stanze di un palazzo parigino, con i loro occupanti e tante storie che si incastrano tra loro). Un puzzle che si rivela alla fine essere la vita stessa dell’autore.
Il primo pezzo di questo puzzle è la fascinazione ossessiva per gli oggetti: Perec riserva un’attenzione estrema, alla descrizione delle cose di uso comune, quotidiano, tanto più marginali quanto più meticolosamente elencate e/o descritte nei particolari, iperrealisticamente. Anche qui, a dispetto dell’apparente neutralità di uno sguardo che sembra distaccato nel cogliere la superfice –in senso stretto- della realtà nei suoi aspetti minimi, non considerati quasi mai dalla Storia e solo occasionalmente dalla letteratura, il risultato artistico è invece un contatto profondo con l’essenziale -se ce n’è uno- narrativo ed umano, un’esperienza emozionante: le cose evocano e descrivono in profondità, con l’indispensabile strumento della memoria.
La memoria, dunque, ed in particolare quella che abbraccia ciò che Perec stesso chiama l’ ‘infraordinario’: “…tentare di cogliere non ciò che i discorsi ufficiali (istituzionali) chiamano l’evento, l’importante, ma ciò che è al di sotto, l’infraordinario, il rumore di fondo che costituisce ogni istante della nostra quotidianità” . Questo ‘al di sotto’ costituisce il tema di ‘Mi ricordo’ (1978), un disarmante e felice catalogo di piccolissime rievocazioni: frasi di una riga o due che iniziano con “Mi ricordo”. Perec lo definisce “Un frammento di autobiografia… si tratta in fondo di ritrovare o conservare la traccia di una pratica quotidiana di cui né la Storia né la Letteratura si fanno carico”
E quindi, strettamente connessa alla memoria, quella che è stata definita ‘la vertigine tassonomica’: il ricorso frequentissimo agli elenchi, alle enumerazioni, agli accumuli: si ritrovano in Perec intere pagine contenenti le più svariate forme di elencazione: cataloghi commerciali, liste di tutti gli oggetti presenti in un determinato spazio, liste della spesa, bibliografie e così via.
 A questo punto si potrebbe essere tentati, non conoscendolo, di immaginare un autore genialoide, ma sostanzialmente marginale, incline al frammentario, all’eccentrico, al virtuosismo privo di sostanza letteraria, e della cosiddetta (e spesso un po’ equivoca) profondità. Sarebbe un grosso errore. Le pagine di Perec sono permeate di passione narrativa, del piacere di raccontare storie, di un nutrimento letterario vastissimo e assai poco pedante, e di una capacità di toccare luoghi oscuri, felici, essenziali, dell’anima.
A questo punto si potrebbe essere tentati, non conoscendolo, di immaginare un autore genialoide, ma sostanzialmente marginale, incline al frammentario, all’eccentrico, al virtuosismo privo di sostanza letteraria, e della cosiddetta (e spesso un po’ equivoca) profondità. Sarebbe un grosso errore. Le pagine di Perec sono permeate di passione narrativa, del piacere di raccontare storie, di un nutrimento letterario vastissimo e assai poco pedante, e di una capacità di toccare luoghi oscuri, felici, essenziali, dell’anima.
In appendice a ‘La vita…’ ci sono, oltre ad un’indice analitico dei luoghi e personaggi veri od immaginari che popolano il libro ed ad una pianta del palazzo, l’elenco delle storie narrate e degli autori il cui materiale ha fornito ispirazione per l’opera: Perec, appassionato lettore, metabolizza e ricrea, a partire dal piacere che la letteratura gli offre, un repertorio narrativo ampio e privo di snobismi; da Kafka a Verne, da Joyce al romanzo poliziesco a Borges. E proprio a partire da quest’ultimo, a lui particolarmente affine, ci si può avvicinare ad un’ipotesi di svelamento, di connessione, di senso ultimo del suo scrivere.
La memoria è tema classicamente borgesiano: il Funes di ‘Finzioni’ consuma la parte finale della sua giovane vita nella condanna di una memoria ‘totale’, inesorabile. Una memoria che lo costringe a percepire e ricordare ogni minuto dettaglio di ciò che ha visto. E la memoria diventa metafora della sopravvivenza fisica delle cose nel regno di Tlön (gli oggetti che nessuno vede o ricorda più, svaniscono). E se le cose, gli oggetti, sono in Perec strumenti attivatori e al tempo stesso oggetto, appunto, di memoria, descrizione del mondo e ricostruzione di identità, l’atto di elencarli, di ricordarli tutti, senza eccezioni, diventa necessario per la salvaguardia della realtà, e dell’identità personale. Se, come ancora in Borges (nell’Aleph, il “luogo dove si trovano, senza confondersi, tutti i luoghi della terra, visti da tutti gli angoli” , o nella Biblioteca di Babele) c’è in Perec il tentativo dell’onniscienza (percepire, ricordare, “censire TUTTO” ), c’è anche la consapevolezza dell’inevitabile fallimento (“dimenticare comunque qualcosa” ).
C’è qualcosa di più profondo in questa attitudine. Emerge l’ansia della perdita, della sparizione (La Disparition). E il disegno del puzzle comincia a delinearsi meglio. Elencare, descrivere, per non perdere irrimediabilmente. Dice Perec in un’intervista: “… per me la vita è un’energia considerevole (…) per niente… che finisce nella morte. E dopo che cosa resta? Restano degli oggetti. Infine, è ciò che sopravvive, e attraverso essi direi che c’è qualcosa di molto commovente…” . Il vuoto, la morte si fanno avanti come protagonisti del suo scrivere, il gioco trasfigura nell’immagine dell’abisso. E la scrittura è quindi “cercare meticolosamente di trattenere qualche cosa, di far sopravvivere qualche cosa” .
Georges Perec era ebreo. Figlio di polacchi emigrati in Francia, perse il padre a quattro anni -ucciso in guerra-. La madre fu deportata ad Auschwitz tre anni dopo e non tornò. Questo orfano precoce visse così la prima, fondamentale, tragica, oggettiva sparizione della sua vita. Più tardi, a partire da questo elemento di esperienza, cominciò ad interrogarsi sulla propria storia personale per comprendere quanto la Storia, quella ‘grande’, l’abbia invasa e sopraffatta, plasmata in maniera determinante: l’essere ebreo, inizialmente era “il segno di un’assenza, di una mancanza, non di un’identità”. Perec dice di aver cominciato a sentirsi ebreo quando, alla ricerca delle radici della propria famiglia prese coscienza “di questa appartenenza ad una cultura fondata sull’esilio e sulla speranza, sul cancellare e sul rifare” . Lo sradicamento, il senso dell’assenza, l’angoscia dell’annullamento, della morte si scoprono quindi come dati reali, concreti. Il puzzle prende una forma insospettata.
“… niente mi è dato, mi tocca acquisire tutto (…). Non ho casa, né famiglia, né granaio, come si dice, non ho radici, non le conosco (…). E quanto cerco attraverso la scrittura è di lasciare tracce nella mia memoria. Da qui, forse, la mia passione per i dizionari, perché i dizionari sono la memoria degli uomini” .