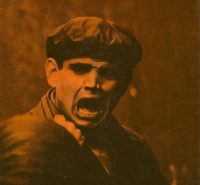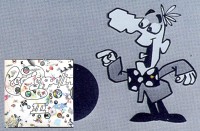Ricopio qui, per la pazienza di coloro che vorranno leggerselo tutto (è piuttosto lungo) l’articolo di Ennio Flaiano che ho letto durante la manifestazione di cui parlavo qui. Ci vuole un po’ di pazienza, ma ne vale la pena.
 Signor Direttore, collaborando al Suo giornale con queste note di diario mi sono fatto una piccola e riprovevole fama di uomo forse intelligente ma arido. La verità è il contrario: sono certamente un cretino, ma umido. Debbo infatti ammettere che credo ancora nelle idee che mi sono state inculcate da ragazzo, sui banchi della scuola, e non saprei non dico tradirle, ma nemmeno immaginare altre che le sostituissero: segno quindi che sono inadatto ai tempi, i quali richiedono versatilità e immaginazione. Io credo, per esempio, nella Libertà e di questo vorrei parlarle. Uno dei momenti più felici della mia disordinata giovinezza fu quando lessi questa semplice frase, che mi spiegava tutto il mio amore: “La Storia è storia della lotta per la libertà”. Quest’amore per la parola Libertà non sopportava aggettivi né associazioni: io non volevo una libertà sorvegliata, difesa, personale, intellettuale; né gradivo che le si accoppiassero concetti, altrettanto nobili, come Giustizia e Democrazia, parendomi che la libertà li contenesse tutti, anzi li proteggesse. Quest’amore per la libertà è l’unico errore giovanile che io non rifiuto e che condiziona tutti i miei errori di oggi. Ma poiché questi errori mi aiutano a vivere, mi rendono anzi la vita sopportabile, io li difendo. Ora che le ho fatto il quadro abbastanza desolato povero della mia filosofia, siamo maturi per giudicarla. Purtroppo, dovremo prendere le cose un po’ alla larga e ripetere argomenti ovvi, ma possiamo permettercelo.
Signor Direttore, collaborando al Suo giornale con queste note di diario mi sono fatto una piccola e riprovevole fama di uomo forse intelligente ma arido. La verità è il contrario: sono certamente un cretino, ma umido. Debbo infatti ammettere che credo ancora nelle idee che mi sono state inculcate da ragazzo, sui banchi della scuola, e non saprei non dico tradirle, ma nemmeno immaginare altre che le sostituissero: segno quindi che sono inadatto ai tempi, i quali richiedono versatilità e immaginazione. Io credo, per esempio, nella Libertà e di questo vorrei parlarle. Uno dei momenti più felici della mia disordinata giovinezza fu quando lessi questa semplice frase, che mi spiegava tutto il mio amore: “La Storia è storia della lotta per la libertà”. Quest’amore per la parola Libertà non sopportava aggettivi né associazioni: io non volevo una libertà sorvegliata, difesa, personale, intellettuale; né gradivo che le si accoppiassero concetti, altrettanto nobili, come Giustizia e Democrazia, parendomi che la libertà li contenesse tutti, anzi li proteggesse. Quest’amore per la libertà è l’unico errore giovanile che io non rifiuto e che condiziona tutti i miei errori di oggi. Ma poiché questi errori mi aiutano a vivere, mi rendono anzi la vita sopportabile, io li difendo. Ora che le ho fatto il quadro abbastanza desolato povero della mia filosofia, siamo maturi per giudicarla. Purtroppo, dovremo prendere le cose un po’ alla larga e ripetere argomenti ovvi, ma possiamo permettercelo.
Da tempo il mondo ha in sospetto la Libertà; e i popoli, attraverso i loro rappresentanti, fanno di tutto per darle un altro nome, meno risibile: col risultato che ideologie contrarie e opposte vengono chiamate con lo stesso nome, portando la confusione delle idee a quel punto critico che impedì ai costruttori della Torre di Babele di proseguire la fabbrica. Ma che cos’è questa confusione di idee se non una delle prove più smaglianti dell’esistenza della Libertà e del poco rispetto di cui viene circondata? Lei potrà rimproverarmi che la Libertà che io amo è una pura astrazione e che con argomenti simili non si costruisce il mondo di domani, anzi se ne distruggono i progetti. Perché amare una parola, per se stessa, non porta a nulla se non ad un’adorazione assurda, lontana dalla vita e dal suo svolgersi, quindi dalla Storia.
Io dunque, limitandomi ad un culto privato della Libertà, non sono inserito nei miei tempi. Vorrei cavarmela, insomma, e salvare la faccia, amando la Libertà: impegno che non mi costa nulla, perché l’amiamo tutti ovviamente, anche se ognuno dandole un diverso scopo e significato. Per difendere questa Libertà che io dico di amare, io dovrò invece definirla, darle un programma, rifletterla nei miei scritti, farle dei proseliti. Ebbene, direi di no. Questo mi sembrerebbe il più assurdo dei disegni perché io penso (guardi fin dove giunge il mio amore) che la Libertà è una forza vitale che può essere oscurata, mortificata ma non soppressa e che ogni uomo, in un preciso momento della vita, impara veramente ad amarla; ma che pretendere di anticipare questo momento è avventato anzi illiberale. La libertà, voglio dire, per alcuni è un dono, che trovano sul cuscino nascendo, portato da un benefico caso, per altri è una conquista, che tentano – qui è il punto – di ostacolare essi stessi con tutte le loro forze, di rifiutare con ogni argomento, dal più facile al più capzioso, dal più onesto al più politico. Noi della nostra generazione, signor direttore, abbiamo avuto un privilegio (non diciamo triste perché da esso tiriamo le nostre poche soddisfazioni) di credere subito nella Libertà e quindi di poter prevedere quello che sarebbe accaduto, molto prima che realmente accadesse. Povere Cassandre in un mondo mobilitato per le guerre, stimiamo un vero successo l’essere sopravvissuti alle nostre facili profezie sul trionfo finale della Libertà. Noi eravamo tra i pochi, anzi pochissimi, che nel settembre del ’39, quando la guerra scoppiò, sapevamo l’intreccio della tragedia e volentieri avremmo saltato i primi quattro atti per arrivare al quinto, poiché era nel quinto che entrava in scena il nostro amato personaggio, con la fiaccola in mano. Noi fummo quei pochi che ridemmo (un riso ben amaro, ma del resto non si poteva piangere) quando Mussolini, dall’alto del suo balcone, disse che l’entrata in guerra dell’America lo lasciava perfettamente indifferente. Noi pensammo, allora, che restare indifferenti a tale notizia era il segno che la Libertà rende ciechi coloro che vuol perdere. col volgere degli anni ci toccò fare altre profezie, tutte malinconicamente esatte, e dalle quali non c’era da tirar vanto, perché si trattava sempre della prima profezia, che doveva esaurirsi. Tuttavia l’essere restati fedeli a quell’idea ci ha attirato dapprima il disprezzo e infine l’odio di coloro che, adattandosi giorno per giorno alla realtà apparente (e quindi mendace), finiscono per dimenticare che c’è una realtà superiore, che muove i popoli e gli avvenimenti, e che questa realtà è una scienza esatta, coi suoi postulati, teoremi e corollari che si chiama… ma si, ripetiamolo, che si chiama Libertà.
Un tale disprezzo ha finito talvolta per inorgoglirci. Nelle lotte dei popoli, come in una sinfonia che ormai conosciamo a memoria, finito il chiasso degli ottoni, sappiamo che gli archi riprenderanno il semplice enunciato del teorema, che ispirò il musicista e che per dimostrare il quale, ha dovuto scrivere la sinfonia, anche eccedendo in sonorità e interpolazioni. Noi guardiamo oggi ai paesi d’oltre cortina. Pochi anni sono bastati a quei popoli per dimostrare, per assurdo, il nostro teorema: una dimostrazione tanto facile, che quasi ci sgomenta, perché non l’avevamo prevista così rapida. E benché sappiamo che quei popoli saranno ancora per lungo tempo sottomessi al giog0 che hanno accettato pieni di speranza, sappiamo anche che oggi lo trovano innaturale e che una luce si sta facendo strada nel loro ragionamento. Questo ci basta. Perché la Libertà ha un sapore che non si dimentica facilmente e che spinge a tutti gli eccessi coloro che ne restano privi, o che se ne sono voluti privare nella certezza di poterne fare a meno. Noi ora aspettiamo l’evoluzione di questi eccessi. A questo punto lei, pur convenendo col mio modesto ragionamento, mi pregherà di volerne tirare il succo, per quel che ci riguarda. G1usto. Noi siamo un popolo in pace con la Libertà, siamo un Paese libero, con una stampa libera e un Parlamento liberamente eletto. Ma la Libertà per noi, ottenuto il suo primo successo di curiosità, è oggi divenuta una realtà talmente quotidiana che quasi ci infastidisce con i suoi eccessi e della quale talvolta elenchiamo i difetti. Pretendiamo anche che ci dia tutto, col nostro minimo sacrifcio, la consideriamo come qualcosa di estraneo, un Ente, di cui qualcun altro farà le spese. Non siamo ancora riusciti ad accettare questo postulato, il più importante di tutti: che la Libertà siamo noi. Ci consideriamo staccati da essa, non più suoi amanti, ma padroni e già in quel pericoloso stato danimo di insoddisfazione che una fedeltà troppo facile e alla lunga pesante istilla nei coniugi: «Faute de mieux nous couchons avec la Liberté». Per noia, arriviamo ad augurarle la morte o almeno una malattia grave. Così oggi in ogni italiano sonnecchia un infedele, pronto a sottomettere «temporaneamente» la Libertà, per poterla restaurare, abbellire, ampliare, completare. Abbiamo da una parte il forte partito comunista che ha per disperato scopo di spiegarci, con un ritardo di dieci anni, quel che ci succederebbe se si instaurasse qui un governo comunista: come se noi non lo sapessimo. Ma questa eventualità non ci preoccupa. Il partito comunista noi lo rispettiamo non per le conclusioni alle quali non arriverà mai, ma per il semplice fatto che esiste. Oggi il comunista è un partito conservatore e reazionario, che non vuole fare rivoluzioni e si accontenta che gli altri partiti lo credano capace di farle. E i pochi futuri amanti della Libertà che l’avvenire ci riserba oggi soffrono la loro crisi proprio nelle file di questo partito.
Dall’atra parte abbiamo un partito confessionale – economico, talmente vasto che lo si potrebbe scambiare per la volontà degli italiani, se non sapessimo che a dirigerlo è una volontà che ha sempre avversata l’idea stessa di un’Italia libera. Questo partito, fortemente involuzionario, dovrà ricorrere alla rivoluzione per mantenersi al potere e scacciare quella libertà che sa di eresia e puzza di zolfo. Non credo, signor direttore, che nessun altro Paese al mondo si trovi in una simile assurda antistorica situazione: i due partiti più forti del nostro Paese non amano il loro Paese, non lo amano cioè libero, ma occupato, da loro beninteso, per poterlo rendere degno di questa Terra e di quel Cielo.
C’è da chiedersi: come si è potuta creare una situazione tanto assurda e pericolosa? La risposta è una sola: il nostro sospetto per la Libertà. Noi non abbiamo ancora esaurito tutto il disgusto per una Libertà che non volevamo, che ci è stata imposta dagli avvenimenti e che usiamo a consumazione, aspettando che si esaurisca. Noi italiani odiamo la Libertà; e la prova maggiore che io porto a sostegno di tale tesi è il gran numero di monumenti eretti nel nostro Paese ai martiri della Libertà, che sono sempre morti per difenderla. Noi amiamo la Forza e la Libertà sta sempre dalla parte dei deboli, che muoiono.
Se oggi voglio trovare una persona che condivida il mio stesso totale amore per la Libertà debbo, signor direttore, interrogarne duecento: questo ci dicono le statistiche. Dunque la mia posizione, come sembrava in un primo momento, non è affatto comoda, potendo io restare senza interlocutori, quasi isolato, facilmente deriso e probabilmente morto. Né ci resta il conforto d’aspettare le rivoluzioni. Le rivoluzioni che l’Italia può oggi permettersi e che fatalmente si permetterà, sono di ripiego, timide, rivoluzioni approvate dallo stato, fatte con l’aiuto dello stato e dirette contro la Libertà, ma proclamate in nome della Libertà: un sinistro pasticcio. Da qui il mio sentimento verso la Libertà, che io amo senza illudermi di poterla sposare, sapendo anzi che dovrò prepararmi ad un’altra (ventennale?) relazione clandestina: una relazione disapprovata da tutti, in alto e in basso, a destra e a sinistra. Questo dunque il mio impegno che, dandomi una certa lucidità nel giudicare gli avvenimenti, mi spinge a fare della Libertà un culto privato, personale, niente affatto arido (perché mi sorregge la speranza di essere imitato dalla maggioranza degli italiani) ma purtroppo cretino (perché la maggioranza degli italiani ha altro a che pensare).
« Il Mondo ››, 6 novembre 1956
Incluso ne “La solitudine del Satiro”